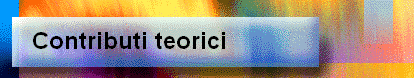
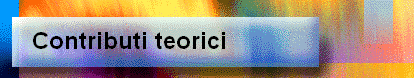
ALLA SCOPERTA DEL CURRICOLO NASCOSTO:
LE CONVINZIONI DEGLI INSEGNANTI E DEGLI STUDENTI
Per la Storia Mail, Newsletter Bruno Mondadori, n. 16, 2008
Luciano Mariani
Un “incidente critico”
Il popolo Inuit vive nella parte settentrionale del Nord America. Ci si riferisce spesso a loro come “Esquimesi”, anche se questo è un termine che essi non amano. Tempo fa, durante un incontro tra insegnanti e genitori in una scuola locale, a un certo punto un insegnante (canadese) disse a un genitore Inuit, “Suo figlio partecipa bene in classe … interviene molto, fa molte domande“ – e, con sua grande sorpresa, si sentì rispondere, “Oh, mi spiace, mi spiace davvero“.
C’era stato evidentemente uno scontro di aspettative. L’insegnante intendeva lodare la partecipazione dello studente, partendo dalla presunzione che i ragazzi a scuola dovrebbero essere attivi, fare domande, discutere con l’insegnante e i compagni, e così via. Ma il genitore Inuit aveva un’idea completamente diversa: per lei, il ruolo dello studente era sostanzialmente di ascoltare, osservare e in tal modo imparare. Non è possibile apprezzare fino in fondo questa posizione se non si tiene presente che il silenzio è tenuto in grande considerazione nella cultura Inuit: per esempio, se degli adulti non si conoscono bene, spesso rimangono in silenzio anche se stanno seduti vicini.
Le convinzioni, la dimensione nascosta del curricolo
Le scuole sono ambienti di apprendimento istituzionalizzato in cui tutti gli “attori”, dagli insegnanti agli studenti, dai genitori ai dirigenti al personale non docente, fanno parte di una cultura dell’insegnamento e dell’apprendimento fatta di convinzioni, atteggiamenti, valori, tradizioni, convinzioni su ciò che significa imparare, insegnare, “fare” lo studente e “fare” l’insegnante. Nello stesso tempo, queste convinzioni costituiscono la parte più profonda e più nascosta del curricolo, quella parte che influenza le interpretazioni del curricolo e la sua realizzazione concreta. La ricerca ha ampiamente dimostrato che ciò che pensano gli studenti e gli insegnanti della natura di una disciplina, dei modi di imparare e insegnare, e di se stessi in quanto discenti o docenti, condiziona in modo cruciale le intenzioni, le decisioni e i comportamenti. Spesso, convinzioni conflittuali tra insegnanti e studenti e tra studenti e studenti sono all’origine di malintesi e mancate convergenze su obiettivi, metodologie e valutazione del lavoro. Il fatto che le convinzioni profonde siano per lo più implicite, spesso inconsapevoli, e quasi mai portate allo scoperto, le rende ancora più difficili da comprendere e gestire.
Eppure, bastano a volte poche domande per fare emergere e confrontare queste dimensioni nascoste (Scheda 1).
Scheda 1 Descrizioni e/o metafore?
Un modo interessante per sollecitare l'espressione di convinzioni e atteggiamenti consiste nel fornire una serie di affermazioni da completare come descrizione e/o come metafora – ad es.
“Sapere” la mia materia
a) significa …
b) è come ...
Insegnante e studente sono in relazione
a) nel senso che …
b) come …
Si noti che, offrendo una scelta tra descrizione e metafora, si offre l'opportunità di esprimere stili di apprendimento diversi: una descrizione solleciterà di più persone analitiche, sistematiche, convergenti, una metafora persone più globali, intuitive, divergenti. Le metafore, in particolare, possono essere una fonte molto ricca di rielaborazioni, discussioni e scoperte, nel momento in cui la persona, con l'aiuto e lo stimolo dei colleghi, si sforza di chiarire a sé e agli altri i significati anche più nascosti delle proprie affermazioni.
Le convinzioni degli insegnanti
Alcune delle risposte date da un gruppo di insegnanti di materie letterarie sono state:
“Sapere” la mia materia significa …
- muoversi con facilità all’interno della materia, selezionare gli argomenti, collegarli
- conoscere autori e fatti culturali, saperli contestualizzare, recepirne almeno per alcuni il messaggio (quelli che risultano più congeniali, “sentiti” più intimamente), comprendere il linguaggio, individuare le tecniche usate …
“Sapere” la mia materia è come …
- fare un viaggio all’interno di noi stessi
- possedere una chiave che può aprire molte porte
E’ evidente in queste risposte una gamma di convinzioni (o “concezioni epistemologiche”) molto variegata: accanto a chi sottolinea i contenuti e il linguaggio della disciplina e l’elaborazione cognitiva delle relative “conoscenze”, c’è chi insiste maggiormente sulla risposta personale, anche affettiva, e sul valore formativo globale dello studio. Nella stessa ottica, si considerino queste risposte fornite dallo stesso gruppo di insegnanti:
Insegnante e studente sono in relazione nel senso che
- l’insegnante dà nella misura in cui lo studente è in grado di ricevere
- 1) si interagisce per raggiungere obiettivi condivisi; 2) ci si riconosce come individui portatori di significato
Insegnante e studente sono in relazione come
- una guida alpina e la persona che egli conduce in montagna
- un adulto e un ragazzo che, con esperienze diverse, percorrono la stessa strada
Anche in questo caso sembrano delinearsi due concezioni diverse (anche se non proprio alternative) dell’apprendimento: da una parte, l’insegnante che “dà” e “conduce”, dall’altra insegnante e studente coinvolti in modo interattivo per raggiungere obiettivi condivisi seguendo percorsi comuni.
Le convinzioni sono dunque costituite da un insieme di conoscenze, schemi mentali, idee precostituite, supposizioni, teorie implicite o ingenue
- sulla natura di un oggetto di studio (ad esempio, una disciplina o area disciplinare);
- sui meccanismi di apprendimento e di insegnamento (compresi, ad esempio, i tipi di compiti e di strategie implicati, i ruoli svolti da studenti e insegnanti, i criteri di valutazione);
- su se stessi in quanto “apprendenti”, cioè su come le caratteristiche della propria personalità condizionano il processo di apprendimento e i suoi risultati.
Le convinzioni degli studenti
Gli studenti, al pari degli insegnanti, sono spesso disponibili a svelare il “tesoro nascosto” delle loro convinzioni, a discuterle e a confrontarle in gruppo (Scheda 2).
Scheda 2 La voce degli studenti
“Di solito quando devo studiare un argomento che considero noioso o difficile e che magari fa parte di una materia che non è alla mia portata cerco di effettuare uno studio più mnemonico. So che questo metodo è sbagliato perché studiare serve a far funzionare meglio il mio ragionamento però è l’unica soluzione per studiare certi argomenti.” (Giovanna, 18 anni)
“Non ho trovato modi per studiare argomenti difficili anche perché parto già con l’idea che non ci riesco e quindi ci rinuncio completamente e faccio altro pensando di recuperare col prossimo argomento.” (Linda, 15 anni)
“Se l’insegnante è capace e in famiglia si ha un supporto, anche solo morale, si è portati ad un buon risultato del lavoro (se si unisce lo studio!).” (Antonio, 16 anni)
Si noti che Giovanna possiede convinzioni ben radicate su che cosa significhi “studiare”: ha ben chiara la differenza tra “ragionamento” e “studio mnemonico”, e riconosce i limiti di quest’ultimo, anche se la scelta del metodo (cioè il suo comportamento effettivo) è poi determinata dal suo rapporto con le diverse materie e i diversi argomenti. Da parte sua, Linda scopre il lato personale delle sue convinzioni, in questo caso le sue percezioni di competenza negative, che la portano ad un’aspettativa di fallimento e, di fatto, ad un comportamento di evitamento: sembra però anche consapevole della sua illusione di “recuperare col prossimo argomento”. Antonio, infine, si rende conto della rete di rapporti che costituisce il contesto di un buon apprendimento: assegna a ciascuna parte il ruolo che le compete, riconoscendo in modo piuttosto equilibrato l’interazione di fattori quali l’impegno dello studente, la capacità dell’insegnante e il sostegno della famiglia.
Fuoco sulla storia Ma chi studia storia a scuola “pensa” come gli storici?
Uno studio molto interessante condotto dal Prof. Samuel S. Wineburg dell’Università di Washington ha messo a confronto i modi di leggere testi storici di vario tipo (sia fonti primarie che secondarie) da parte di storici e di studenti di scuola superiore. Sono risultate differenze molto significative, che non attengono tanto alla diversa quantità delle preconoscenze possedute, né alle strategie di lettura e di comprensione testuale, quanto piuttosto alle convinzioni profonde su come sono costruiti i testi storici e sul ruolo che il lettore/storico può e deve giocare. Si considerino alcune delle differenze emerse in questo studio:
Gli “esperti” tendono a … |
Gli “studenti” tendono a … |
- chiedersi che cosa fa il testo (lo “scopo”) - capire sia gli scopi espliciti dell’autore (e il linguaggio che usa per influenzare il lettore), sia le sue presunzioni e pregiudizi nascosti o inconsapevoli - considerare i testi come costruiti da persone che hanno una loro visione degli eventi e del mondo - prendere in considerazione la scelta delle parole (le connotazioni e le denotazioni) e il tono del discorso - confrontare testi diversi per valutare resoconti differenti dello stesso evento, interessandosi così alle contraddizioni e all’ambiguità |
- chiedersi che cosa dice il testo (i “fatti”) - capire i significati letterali del linguaggio dell’autore
- considerare i testi come resoconti di ciò che è effettivamente accaduto, come descrizioni del mondo neutre e obiettive - ignorare scelta delle parole e tono del discorso - cercare e imparare la “risposta giusta”, risolvendo o ignorando contraddizioni e ambiguità |
Wineburg illustra con una potente metafora queste diverse convinzioni e atteggiamenti: “Gli storici studiarono questi documenti come se fossero il pubblico ministero, non si limitarono ad ascoltare le testimonianze ma le sollecitarono attivamente mettendo i documenti l’uno accanto all’altro, localizzando discrepanze, esaminando attivamente le fonti ed immergendosi nelle loro motivazioni consce e inconsce. Gli studenti, invece, si comportarono come giurati, ascoltando pazientemente le testimonianze ed interrogandosi su quanto sentivano, ma incapaci di interrogare direttamente i testimoni o di sottoporli a un controinterrogatorio. Per gli studenti, la fonte dell’autorità era il testo, mentre per gli storici erano le domande che essi stessi formulavano sul testo”.
Qualche implicazione … e qualche cautela
In quanto dimensioni nascoste, le convinzioni sono rilevabili soltanto tramite la raccolta di informazioni e l’osservazione dei comportamenti, ossia ascoltando o leggendo ciò che dicono o scrivono le persone e osservando i loro comportamenti. Dai dati così raccolti si possono poi inferire delle possibili spiegazioni, che non possono però che costituire ipotesi. In altre parole, le informazioni raccolte, ad esempio tramite un questionario, devono essere validate correlandole con altre fonti di informazioni, ad esempio con interviste, discussioni, e il confronto delle conoscenze che in proposito hanno persone diverse (studenti, insegnanti, genitori …).
Inoltre, le convinzioni sono solo relativamente stabili, nel senso che sono soggette a modifiche in base alle nuove conoscenze ed esperienze delle persone – e questo a maggior ragione nell’età evolutiva.
Infine, è rischioso istituire un rapporto unidirezionale di causa ed effetto tra convinzioni, da una parte, e scelte o comportamenti, dall’altra. La complessità delle motivazioni umane non permette di prevedere ad esempio che, date certe convinzioni, le persone si comporteranno in un certo modo (o viceversa). Occorre non dimenticare il ruolo dei contesti, cioè le caratteristiche degli ambienti di apprendimento che possono influire sui comportamenti effettivi di insegnanti e studenti al di là delle loro convinzioni dichiarate.
Pur con queste doverose cautele, portare allo scoperto convinzioni e atteggiamenti, verbalizzarli e socializzarli, vederne il carattere soggettivo e relativo, può aprire importanti spazi di confronto e discussione in classe. In particolare, una volta esplicitate le proprie convinzioni, può essere più agevole, alla luce di nuove esperienze e della riflessione su di esse, farle evolvere, non in modo forzato ma come il naturale aggiornamento delle proprie percezioni. L’esplorazione del curricolo nascosto aumenta così la consapevolezza di insegnanti e studenti, mettendoli meglio in grado di rispondere con flessibilità alle richieste degli apprendimenti complessi che la scuola può e deve oggi proporre.
Per saperne di più …
- Sul sito Internet dell’Autore (www.learningpaths.org) sono disponibili questionari, articoli e materiali di riferimento.
- Il citato articolo di Wineburg (“On the Reading of Historical Texts: Notes on the Breach Between School and Academy”, American Educational Research Journal, Vol. 28, No. 3, 1991) è disponibile su Internet all’indirizzo www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/2c/500/91WineburgReadingHistTexts.pdf
- Cantoia M., Imparare: in che senso? Esplorare le concezioni dell’apprendimento. Carocci Faber, Roma, 2007. (Attività didattiche a diversi livelli di scolarità)
- Pérez-Tello S., Antonietti A., Liverta Sempio O., Marchetti A., Che cos’è l’apprendimento? Le concezioni degli studenti. Carocci, Roma, 2005. (Quadri teorici di riferimento e i risultati di una ricerca in Italia)
Torna alla Home Page di Learning Paths – Tante Vie Per Imparare Luciano Mariani, Milano - www.learningpaths.org |