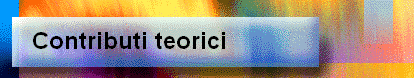
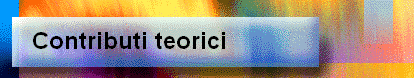
“ASPETTATIVA X VALORE”:
UNA FORMULA PER LA MOTIVAZIONE A SCUOLA?
Per la Storia Mail, Newsletter Bruno Mondadori, n. 11, 2008
Luciano Mariani
In un precedente contributo a questa Newsletter, sulla scorta dei risultati di un mio recente sondaggio tra insegnanti e studenti di scuola secondaria sulla motivazione ad apprendere, avevo offerto alcune considerazioni sul continuum estrinseco-intrinseco e sul ruolo delle attribuzioni causali (1). Vorrei ora continuare questa riflessione discutendo brevemente come si legano due elementi cruciali della motivazione: l’aspettativa di riuscire e il valore attribuito ai compiti di apprendimento. Lo farò, anche questa volta, partendo dalle voci degli studenti (2):
Mi spinge il fatto di raggiungere buoni risultati in
tutte le materie. Questo mi dà un senso di piacere e mi rende contento
perché è una sfida che riesco tranquillamente a vincere. (Pierpaolo,
18 anni)
Normalmente, a scuola mi sento motivato a lavorare in
situazioni non tanto divertenti (come si crederebbe subito) ma piuttosto appassionanti.
Tali situazioni possono comprendere l’uso di macchinari sofisticati o la realizzazione
di esperimenti importanti, per quanto difficili e/o faticosi. (Giulio, 16 anni)
L’ottimismo tranquillo di Pierpaolo nasce dalla percezione di poter affrontare un compito con l’aspettativa di portarlo a termine con successo. E’ una sfida con se stesso che sente di poter vincere poiché le sue esperienze precedenti lo hanno aiutato a costruirsi un senso di autoefficacia, cioè la sensazione di essere in grado di controllare, almeno in buona parte, gli eventi con uno sforzo adeguato e l’impegno delle proprie personali risorse. Ma siamo sicuri che Pierpaolo si impegnerebbe, grazie a questa sua aspettativa di successo, indipendentemente dal tipo di compito che dovesse affrontare? E’ Giulio, in questo caso, ad illuminare l’”altro latro della medaglia”: se Pierpaolo si focalizza su una dinamica motivazionale interiore, Giulio mette infatti l’accento sul significato e il valore dei compiti di apprendimento – o meglio, su come questi vengono percepiti da chi li deve eseguire.
Si noti come Giulio si premuri di precisare con un inciso (“come si crederebbe subito”) che ciò che lo motiva non è tanto il “divertimento”, sfatando così uno dei luoghi comuni che circolano a volte sulla motivazione: che l’apprendimento possa essere anche soltanto piacere, che lo studio debba includere un elemento di divertimento. Non voglio essere frainteso: certamente è più agevole e produttivo studiare in modo piacevole, e se possibile anche divertente, ma mi sembra che Giulio alzi il tono della riflessione su questo aspetto utilizzando un aggettivo più forte e più ricco di sfumature: “appassionante”. E spiega subito con un esempio cosa intende dire: il valore motivante di un compito non ha solo a che fare con la difficoltà (che comunque gli insegnanti cercano di rendere ottimale, ossia adeguata all’attuale livello di competenza degli studenti), né solo con la fatica implicata (cioè lo sforzo personale, che abbiamo visto essere connaturato al senso di autoefficacia). In realtà l’aspetto “appassionante” di un compito o di una situazione di apprendimento è un concetto più sottile, che è centrato in primo luogo sulla percezione del significato, per se stessi, di quello che si sta facendo: ben più, dunque, di un interesse superficiale per un certo argomento e ben più della piacevolezza di una certa procedura di esecuzione. Non è la motivazione intrinseca (il piacere di fare una cosa solo per il gusto di farla), ma un livello qualitativamente alto di motivazione estrinseca, in cui il valore attributo al compito è cruciale.
Mi aiuta il fatto che trovo la storia come un libro
giallo, piena di misteri e intrighi. (Gloria, 13 anni)
Mi sento motivata in quelle materie o in quei progetti
in cui non basta studiare, ma in cui bisogna saper usare la propria testa e
la propria creatività, magari collaborando con altre persone. Insomma
in attività che combinano discipline diverse ed esperienze personali.
(Mara, 17 anni)
In concreto ciò che ha reso questa esperienza
così positiva è stato il fatto che su un unico argomento storico
ho potuto collegare argomenti di altre materie. (Cristina,
14 anni)
Mi sento motivata … quando si mette in pratica ciò
che si è studiato solo teoricamente, e facendo esercizi in classe, guidati
dall’insegnante, in modo da poter poi accorgersi se quell’esercizio saremmo
stati in grado di svolgerlo altrettanto bene da soli. (Roberta, 17 anni)
Come ci suggeriscono questi studenti, il valore motivante di un compito di apprendimento non si può ridurre ad una ricetta standardizzata, ma dipende volta per volta da una combinazione diversa di tante caratteristiche, che però l’insegnante può identificare e tenere almeno in parte sotto controllo. Una griglia di parametri potrebbe ad esempio comprendere, senza essere ovviamente esaustiva:
- la rilevanza: il collegamento evidente con i bisogni, gli interessi, le esperienze personali; l’orientamento ad uno scopo, cioè ad obiettivi chiari ed esplicitati; la percezione dell’utilità e dell’operatività;
- l’attenzione e il coinvolgimento: elementi di curiosità, novità, originalità; la stimolazione all’indagine tramite domande, problemi, ipotesi; e dunque un ruolo attivo e impegnativo per lo studente;
- la varietà e la scelta: varietà nelle modalità di interazione in classe e nei dispositivi (materiali, strumenti, attività) e possibilità di scelta tra compiti, parti di un compito o modalità di esecuzione;
- l’equilibrio tra sfida e sostegno e la conseguente autoregolazione strategica: non solo, come si è già detto, il bilanciamento del livello di difficoltà, ma anche l’equilibrio tra facilitazione da parte dell’insegnante e autonomia da parte dello studente. In particolare, è importante che il compito fornisca al contempo stimoli e sostegni allo sviluppo dell’autoregolazione, proponendo (o facendo emergere) chiare procedure e strategie di esecuzione e di controllo, condividendo criteri di valutazione trasparenti, e promuovendo procedure individuali e collettive di riflessione e autovalutazione.
Dal punto di vista motivazionale, quest’ultimo punto merita di essere sottolineato nella misura in cui, come si è visto, è proprio l’attribuzione del successo contemporaneamente all’impegno e a strategie di esecuzione adeguate che può far progredire la persona verso l’autonomia: un obiettivo ambizioso ma imprescindibile per sapersi motivare, come oggi ci è sempre più richiesto, ad un apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
(1) Si veda “La motivazione ad apprendere: voci dalla classe”, Per la storia Mail, ottobre 2007, Numero 5. Torna al testo
(2) Le citazioni degli studenti sono tratte da Mariani L., La motivazione a scuola. Prospettive teoriche e interventi strategici. Carocci, Roma, 2006. Si veda anche il sito dell’Autore www.learningpaths.org/motivazione Torna al testo
Torna alla Home Page di Learning Paths – Tante Vie Per Imparare Luciano Mariani, Milano - www.learningpaths.org |